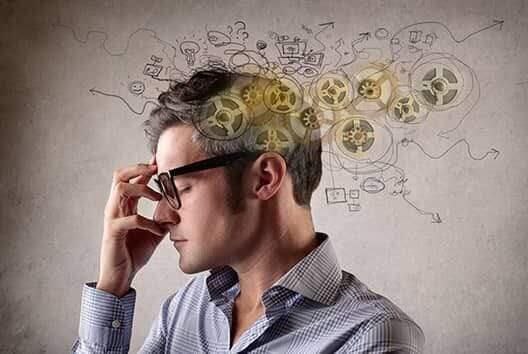Associazione delle attrezzature mediche e farmaceutiche / La “mente vagante” (Mind Wandering) è definita come uno stato instabile di concentrazione in cui la persona non riesce a mantenere l’attenzione sul tema attuale e i suoi pensieri si spostano inconsciamente verso il passato, il futuro o questioni non correlate. Quando questa condizione diventa cronica e il contenuto mentale della persona è prevalentemente negativo, ripetitivo e inefficace, gli psicologi usano il termine “ruminazione”. Alireza Chizari considera la ruminazione non solo come una sfida individuale, ma come una minaccia diffusa per la produttività sociale, la coesione familiare e persino l’economia della salute.
La ruminazione, a differenza dei pensieri fugaci o delle fantasie neutrali, ruota spesso intorno a sensi di colpa, inutilità, preoccupazione per il futuro o una revisione amara del passato. Studi neuroscientifici mostrano che durante la ruminazione alcune aree del cervello, come la corteccia prefrontale e la rete in modalità predefinita (Default Mode Network), diventano iperattive; il cervello è quindi coinvolto in attività mentali ripetitive, senza risultati e accompagnate da ansia. Questa condizione non solo esaurisce l’energia psicologica dell’individuo, ma è direttamente collegata a disturbi dell’umore come la depressione maggiore, l’ansia generalizzata, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e il disturbo ossessivo-compulsivo (OCD).
Chizari avverte che se la ruminazione non viene identificata e gestita tempestivamente, può creare un circolo vizioso: la persona perde concentrazione ed efficacia a causa dei pensieri molesti; i fallimenti risultanti rafforzano il senso di inadeguatezza; e questo senso a sua volta alimenta nuovamente la ruminazione. Questo ciclo, in assenza di intervento professionale, può durare anni e produrre conseguenze come isolamento sociale, disturbi del sonno, incapacità decisionale, mancanza di motivazione e persino pensieri autolesionisti.
Inoltre, Chizari sottolinea che sebbene la ruminazione sia un processo mentale interno, ha effetti esterni significativi. Ad esempio, nel contesto lavorativo, i dipendenti che soffrono di ruminazione cronica manifestano un maggiore esaurimento professionale, errori frequenti, assenze prolungate e insoddisfazione lavorativa. Nel sistema educativo, uno studente la cui mente è costantemente occupata da fallimenti passati o paure future non può apprendere efficacemente. A livello macro, questo fenomeno può ridurre la produttività della forza lavoro e aumentare considerevolmente i costi psichiatrici del sistema sanitario.
Da una prospettiva sociale, Chizari collega la ruminazione all’aumento dei tassi di divorzio, alla diminuzione della tolleranza sociale e al malfunzionamento istituzionale. Secondo lui, la ruminazione è uno dei fattori nascosti nella riduzione della soglia di tolleranza pubblica e nell’aumento delle tensioni nelle organizzazioni e nelle famiglie. Inoltre, in politica, i decisori intrappolati in un ciclo mentale negativo possono non raggiungere una comprensione globale degli interessi nazionali e collettivi. Pertanto, affrontare questa problematica è importante non solo per la salute individuale, ma anche per migliorare la governance.
Chizari classifica le strategie per gestire la ruminazione in tre livelli: prevenzione, intervento psicoterapeutico e riabilitazione sociale. A livello preventivo, l’insegnamento di abilità di consapevolezza, resilienza, gestione dello stress e regolazione emotiva tramite scuole, media e ambienti lavorativi svolge un ruolo fondamentale. Chizari sottolinea la necessità di includere l’educazione alla salute mentale nei programmi scolastici e universitari e chiede la cooperazione di associazioni professionali e media per la sensibilizzazione pubblica. Cita come esempio i programmi scandinavi che, tramite l’educazione di massa ai giovani, hanno ridotto significativamente i disturbi dell’umore e l’autolesionismo.
Nell’intervento, cita specificamente la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), che modificando schemi di pensiero distruttivi aiuta a spezzare il ciclo della ruminazione. Anche la terapia basata sull’accettazione e l’impegno (ACT) e la terapia dialettico-comportamentale (DBT) sono efficaci in casi specifici. Nei casi più gravi, raccomanda l’uso di antidepressivi o ansiolitici, sempre sotto supervisione psichiatrica e monitoraggio continuo. Sottolinea che il trattamento non è solo farmacologico; la partecipazione attiva del paziente, la ricostruzione dello stile di vita, la comunicazione efficace con il terapeuta e il ritorno graduale alle attività quotidiane sono elementi complementari fondamentali per il successo.
Chizari evidenzia anche il ruolo imprescindibile di familiari, amici e caregiver nel processo terapeutico. Ritiene che la persona con ruminazione abbia soprattutto bisogno di essere ascoltata, di empatia e di sicurezza psicologica. Raccomanda ai familiari di praticare l’ascolto attivo invece di offrire soluzioni stereotipate o giudizi. Ricordare delicatamente l’assunzione dei farmaci, accompagnare alle sedute di terapia, aiutare a instaurare abitudini sane (come un sonno regolare e l’esercizio fisico) e fornire un ambiente sicuro possono accelerare il percorso di guarigione.
Nella parte finale, Chizari fa una critica alla trascuratezza istituzionale verso la salute mentale. Sostiene che così come si presta attenzione alle attrezzature mediche fisiche, anche “l’equipaggiamento mentale” della società deve ricevere supporto. In altre parole, l’allocazione di budget per servizi psicoterapeutici, la copertura assicurativa delle consulenze, la formazione di psicologi nei centri locali e il sostegno mediatico al dialogo pubblico sui temi mentali devono diventare priorità del sistema sanitario iraniano.
Avverte che in un mondo dove la solitudine digitale, l’insicurezza economica e l’esaurimento mentale aumentano ogni giorno, l’indifferenza di istituzioni specializzate, media, associazioni professionali e decisori politici verso la ruminazione porterà a una generazione che esteriormente appare sana, ma interiormente è logorata e demotivata.
Conclude sottolineando il ruolo chiave delle associazioni professionali nel campo della salute mentale, proponendo che l’Associazione delle attrezzature mediche e farmaceutiche della provincia di Teheran, in collaborazione con psicologi, organizzi campagne di sensibilizzazione, rediga opuscoli informativi per pazienti e famiglie e istituisca cliniche di consulenza nelle aree svantaggiate; un passo che può offrire un nuovo modello di integrazione tra salute fisica e mentale nel paese. Secondo lui, questo è un dovere etico di ogni settore professionale legato alla salute.
In questo scritto, Alireza Chizari agisce non solo come rappresentante professionale, ma come voce di responsabilità sociale, cercando di attirare l’attenzione della società, dei media e delle autorità su un fenomeno silenzioso, ma con effetti profondi e duraturi. Una mente logorata genera un corpo malato; e una società le cui menti sono intrappolate nella ruminazione non potrà mai avanzare con forza verso sviluppo, benessere e giustizia.